Quando il cigno nero tanto nero non è
i costi del presentismo
Alfonso Falanga, 18 aprile 2024
Premessa 1
La cura, quando è inadeguata, è peggio della malattia.
Una
malattia, oggi, quella che colpisce tutti e in tutto il mondo, è il
cambiamento.
Cambiamento climatico. Geopolitico. Politico. Economico. Sociale. Culturale.
Linguistico.
Chiunque, quando il cambiamento (de)genera una conflittualità, prova più
sgomento di fronte alla cura, se essa è carente, piuttosto a causa della stessa
della criticità. E risulta ancora più drammatico se tale insufficienza non
dipende da mancanza di volontà, dal prevalere di interessi particolari su
istanze generali: insomma, quando non è esito di una scelta consapevole e
ragionata oppure della mancanza di risorse. In Ci riferiamo, invece, ad una vera
e propria incapacità a prevedere, programmare, attuare. È un limite, questo,
che è il risultato di una sorta di mutazione antropologica, avvenuta negli
ultimi trenta quarant'anni, da cui è venuto fuori un individuo-tipo privo di
una particolare funzione: progettare.
È un tratto tipico della nostra società. Che è società tecnologica. Società post-moderna. Post-industriale. Post-ideologica. Società che è post-qualcosa a prescindere, dove quel post indica sempre e comunque il superamento dei tradizionali riferimenti valoriali.
Una società liquida, insomma 1), in cui le abituali zone di comfort sono sostituite da una sola e onnicomprensiva zona di comfort: la pura e semplice attualità, dove il fatto di cronaca prende il posto dell'evento sociale, dove la memoria a breve termine sostituisce la memoria storica e l'informazione, viene scambiata per formazione.
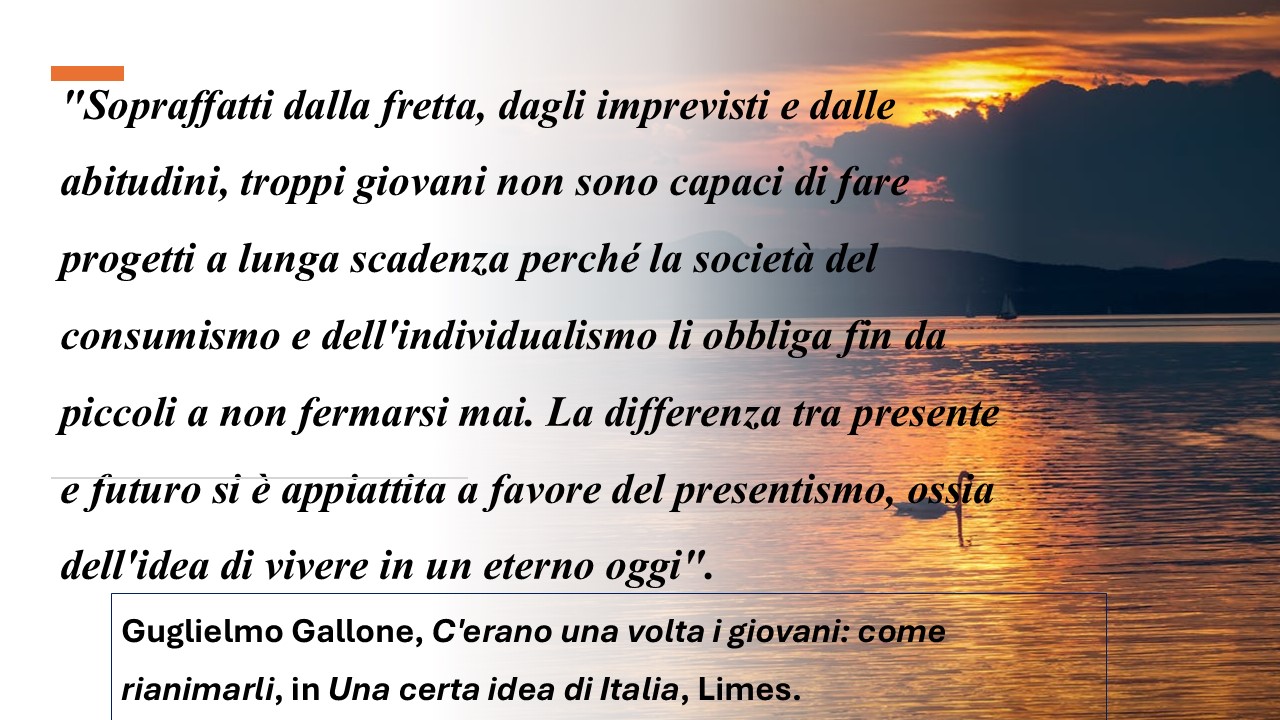
Premessa 2
Nel suo saggio Il Cigno nero. Come l'improbabile governa la nostra vita, Nassim Nicholas Taleb scrive:
"Ciò che qui chiameremo Cigno nero (con la maiuscola) è un evento che possiede le tre caratteristiche seguenti. In primo luogo, è un evento isolato, che non rientra nel campo delle normali aspettative, poiché niente del passato può indicare in modo plausibile la sua possibilità. In secondo luogo, ha un impatto enorme. In terzo luogo, nonostante il suo carattere di evento isolato, la natura mana ci spinge elaborare a posteriori giustificazioni della sua comparsa, per renderlo spiegabile e prevedibile" 2).
Il Cigno nero come alibi.
La denominazione Cigno nero è stata più volte utilizzata, negli ultimi anni, per indicare un evento così fuori dal comune da risultare improbabile, imprevisto ed imprevedibile anche per coloro che, per ruolo e competenze, sono deputati a prevedere, gestire e risolvere problemi di particolare complessità.
Le circostanze che subito vengono in mente al riguardo sono la crisi finanziaria del 2007/2008 3) e la più recente pandemia da covid.
Lo stesso termine viene adoperato, a volte, riferendosi ad eventi la cui imprevedibilità è imputabile, essenzialmente, ad una mancata attività di previsione e programmazione da parte degli esperti del settore più che ad una effettiva eccezionalità dell'evento stesso. Può verificarsi in politica, in economia, nelle scienze, nel mondo del lavoro.
Immaginiamo,
ad esempio, un'azienda che si lasci travolgere dai mutamenti del mercato i cui
segnali anticipatori non siano stati adeguatamente colti dal management o
che, pur cogliendoli, sia risultato sprovvisto di progetti di adeguamento 4).
Così come può esserne interessato anche il singolo individuo, quando resta in
balia degli eventi perché incapace di elaborare un piano di vita che abbracci
le sfere più significative della sua esistenza.

La questione temporale: il presentismo.
Accogliendo l'ipotesi che l'avvento del cigno nero-quando tanto nero non è- sia, in talune circostanze, frutto dell'incapacità a prevedere, è altrettanto legittimo ritenere che questa inadeguatezza sia, a sua volta, esito di una particolare condizione emotivo-cognitiva che caratterizza i nostri tempi: il presentismo.
Per tale si intende una distorta cognizione del rapporto tra se stessi e il tempo e che conduce a percepirsi chiusi in un eterno presente. Si tratta di un tema che, pur se distintivo dell'attualità, certo non è nuovo.
Di presentismo, infatti, si è parlato e si parla in filosofia e in sociologia, nonché in economia e nel mondo del lavoro 5).
Riguardo ai filosofi, basti ricordare Heidegger nel suo voluminoso e incompleto Essere e Tempo 6), oltre alle opere di Jacques Derrida 7). Così come, per la sociologia, risultano di notevole spessore gli studi di Manuel Castells 8), Zygmunt Bauman 9) e Paul Virilio (filosofo)10) sull'alterazione della percezione temporale dovuta alle innovazioni tecnologiche.
Secondo questi autori, il rapporto (o non-rapporto) tra passato, presente e futuro è modellato dall'egemonia del tempo reale, dall'enfasi sulla diretta, dall'esultanza rispetto al basta un click, dall'intendere la rapidità-nel parlare, nel muoversi, nell'agire, nell'apprendere (dunque, nel non-apprendere), nello spostarsi tra luoghi diversi- come naturale sinonimo di efficienza ed efficacia, dal gioire perché si può essere dovunque e in un istante (internet, social, WhatsApp), un dovunque che si estende a tutto il globo e un istante che si ripropone continuativamente attuando un eterno presente che include in sé, annullandoli, passato e futuro.
"Il nuovo sistema di comunicazione digitale si è esteso a tutte le espressioni culturali e ha dato vita a una nuova forma di cultura: la cultura della virtualità reale, che immerge la realtà in un immaginario virtuale. Lo spazio dei flussi produce il superamento dei luoghi e la compressione fino all'annullamento del tempo, il tempo crono, che priva la società della diacronia passato/futuro e quindi della storicità e della storia".
Francesco Barbagallo, I cambiamenti nel mondo tra XX e XXI secolo, Laterza, Bari, 2021.
Presentismo: effetto di un futuro percepito esclusivamente come minaccia.
A questo si aggiunge la visione, ormai radicatasi nell'immaginario sociale, del futuro come minaccia, così è inteso, essenzialmente, per due motivi:
1. abitare un eterno presente rende, inevitabilmente, il futuro un perfetto sconosciuto che, come tutto ciò che non si conosce, è perciò fautore di disorientamento, disagio, ansia, paura. In questa luce, il futuro è qualcosa da evitare. Per farlo, non si può che restare lì dove si è, dunque nel presente 11). Si genera, in tal modo, un corto circuito: il presentismo alimenta la percezione del futuro come minaccia che, a sua volta, rinforza il presentismo.
2. all'orizzonte non si scorgono altro che nubi annunciatrici di guerre, catastrofi climatiche, pandemie, contrazioni delle opportunità di lavoro (quanti impieghi saranno falcidiati dall'IA?), povertà sempre più diffusa, conflitti sociali. Oltre a un vuoto culturale e politico che finisce con l'accreditare la minaccia futura come unico ed inevitabile destino del genere umano.
Anche qui si genera un circolo vizioso: futuro come minaccia che dà origine alla società della paura 12). Paura che, a sua volta, alimenta il presentismo e la conseguente inadeguatezza a prevedere, programmare, gestire tutto ciò che è, idealmente o praticamente, minaccioso.
E quando non si sa prevedere e non si è in grado di programmare, è inevitabile che l'orizzonte diventi abitato solo da cigni neri.
L' affermarsi della veduta corta nelle élite.
La veduta corta, per citare il titolo di un saggio di Padoa-Schioppa 3), è un fenomeno trasversale all'intera la società: ci riguarda tutti, che si sia "cittadini comuni" o che si appartenga a quella particolare categoria di privilegiati che, per lavoro e-appunto-per privilegi, dovrebbe volere e sapere prevedere, programmare, gestire, risolvere criticità annunciate e non annunciate. Il presentismo è, ormai, una naturale condizione cognitiva ed emotiva di questa élite, che si declina nel suo modo di lavorare. Programmare, insomma, non è previsto perché non esiste, nel sistema di riferimento di questi privilegiati, la dimensione in cui quel programma dovrebbe poi tradursi in comportamenti attuativi: ovvero, il futuro.
L'assenza di programmazione come effetto dell'individualismo.
La veduta corta è anche figlia di una società individualista qual è la nostra (particolarmente dalla metà degli anni Settanta del XX secolo in poi) (individualismo momentaneamente scalfito dalla ventata di solidarismo- più declamato e promesso che realizzato- negli anni del covid), che poggia su un modello economico-sociale in cui emergono gli interessi individuali più che collettivi, che si concentra sull'immediato (al più, sul medio termine) invece che sul lungo termine: un modello sociale che prevede un tipo di individuo privo di orizzonti-che non sia il prossimo weekend o la prossima estate o il prossimo Natale- e dotato di un' estensione temporale che coincide al massimo con la durata della propria esistenza.
Si
tratta di un modello in cui l'obsolescenza è una costante: tutto è già vecchio
prima ancora di affermarsi come novità. E per tutto si intende oggetti,
rapporti, conoscenze.
L' eterno presente è causa/ effetto di una accelerazione temporale che azzera
le differenze, le specificità, le innovazioni. Le pause. Produce tutt'al più un
passato esclusivamente sotto forma di memoria/deposito. Ingombrante, dunque.
Un impiccio di cui liberarsi quanto prima 13).
Quindi?
Dopo tanto bel parlare, ci si aspetterebbe una soluzione.
Soluzione
che, in effetti, non è tanto difficile da formulare. Infatti, non c'è altro da
fare che ripristinare prospettive temporali ed attitudini cognitive e
comportamentali del passato e farlo coinvolgendo, in questo processo, individui
ed intere collettività:
il fatto è che proprio questa semplicità è segno di inattuabilità.
Eppure…eppure bisogna fare qualcosa pur nella consapevolezza che indietro non
si torna.
Il futuro avanza, un futuro che la veduta corta non sa, non vuole, non riesce a
scorgere. Un futuro con le sue opportunità e le sue minacce. Un futuro che
richiede con urgenza che vengano elaborate solide basi per risolverne le
criticità e approfittare delle sue risorse.
La
radicalizzazione della veduta corta nell'immaginario sociale, pertanto, non
deve azzerare necessariamente i margini di manovra di un'azione quantomeno
individuale e che riguardi i segmenti più significativi della propria
quotidianità.
Il che non significa ridurre il tutto ad una mera estensione dell'agenda degli
appuntamenti bensì promuovere, per sé e in sé, un cambio di prospettiva che
sostituisca -nell'ambito del proprio agire - l'obiettivo con lo scopo.
Qualora ciò si realizzasse, sarebbe un buon punto di partenza per ripristinare,
almeno individualmente, una veduta più ampia, o il meno corta possibile, e
riattivare l'attitudine alla programmazione.
Ciò che qui si sta suggerendo, in sostanza, è un cambiamento. Cambiamento di prospettiva temporale che poi si declina in cambiamento di stili comportamentali, di scelte di vita, di più complessi ed estesi stili di vita
NOTE
1) Cfr. Zygmunt Bauman, Modernità liquida (Liquid Modernity, 2000), tr. Sergio Minucci, Laterza, Bari, 2024.
2) Nassim Nicholas Taleb, Il Cigno nero (The Black Swan, 2007), tr. Elisabetta Nifosi, ilSaggiatore, MI, 2008, p. 11.
3) "Nel novembre del 2008 la regina Elisabetta d'Inghilterra si è recata in visita alla London School of Economics. Con sorpresa generale ha chiesto ai suoi sapienti interlocutori: «Perché nessuno ne se è accorto?». E ha continuato: «Se queste cose erano tanto grosse, com'è che tutti le hanno trascurate? È orribile» [...]Allora, com'è possibile che questa crisi sia potuta scoppiare sotto gli occhi di migliaia di banchieri centrali, uomini politici, regolatori pubblici, giornalisti economici, professori universitari, analisti finanziari?".
Tommaso Padoa-Schioppa, La veduta corta, il Mulino, Bologna, 2009, p. 9.
4) Il primo esempio al riguardo è quello di Blockbuster LLC, travolta dall'"inaspettato" avvento della Tv via cavo. E si potrebbe continuare con le episodiche crisi dell'industria automobilistica fino al più recente lamento, nel nostro paese, del settore ristorazione riguardo alla mancanza di personale, attribuito, a volte, alla mancanza di voglia di lavorare dei giovani, altre ai sussidi governativi ma raramente prendendo in considerazione la mancanza di progetti di adeguamento del settore alle mutate condizioni economiche e socio-culturali della società post-pandemica.
5) Presentismo è il termine con cui si indica, nel mondo del lavoro e delle professioni, il superamento dei limiti temporali nello svolgimento delle proprie mansioni: in pratica, lavorare a qualsiasi ora e per più ore rispetto al previsto. Fenomeno, questo, alimentato particolarmente dall'uso delle tecnologie informatiche. Si pensi allo smart working e alla sua intensificazione in epoca covid: se, durante il lockdown, tale modalità ha permesso di ovviare all'impossibilità del lavoro in presenza, allo stesso tempo ha generato fenomeni diffusi di burnout.
6) Cfr. Martin Heidegger, Essere e Tempo, (Sein und Zeit, 1927), tr. Pietro Chiodi, Longanesi, Milano, 1976.
7) Cfr. Jacques Derrida, Margini della filosofia (Marges de la philosophie, 1972), trad. Manlio Iofrida, Einaudi, Torino 1997.
8) Cfr. Manuel Castells, Galassia Internet (The Internet Galaxy,
Reflections on the Internet, Business and Society, 2001) trad. Silvia
Viviani, Feltrinelli, Milano, 2002;
La nascita della società in rete (The Rise of Network Society, 1996)
tr. Lara Turchet, Università Bocconi Milano, 2002.
9) Cfr. Zygmunt Bauman, Il teatro dell'immortalità. Mortalità, immortalità e altre strategie di vita (Mortality. Immortality and Other Life Strategies, 1992.), tr. Giovanni Arganese, Il Mulino, Bologna, 1995.
10) Cfr. Paul Virilio, La bomba informatica (Le bombe informatique, 1999) tr. Giovanni Piana, Raffaello Cortina, Milano, 2000.
11) Dal futuro minaccioso si scappa anche rifugiandosi nel passato, nella memoria e nella tradizione. Ciò dà origine ad atteggiamenti individuali o collettivi fondati su pregiudizi, zone di comfort, rifiuto di ogni accenno alla novità. A livello individuale, è prerogativa di fasce di età più adulte. A livello sociale, è un tratto culturale-politico di categorie sociali vincolate ai loro privilegi che sentono diventare sempre più precari di fronte all'avanzare del nuovo (ogni cosa futura è nuova, ed ogni cosa nuova è una minaccia).
12) Cfr. Zygmunt Bauman, Paura Liquida (Liquid fear, 2006), tr. Marco Cupellaro, Laterza, Bari, 2008.
Cfr. Carlo Bordoni, Stato di paura, Castelvecchi, Roma, 2016.
13) Fabio Merlini, Silvano Tagliagambe, Catastrofi dell'immediatezza, Rosenberg & Sellier, 2016 Torino.