Eduardo!
Alfonso Falanga, 6 aprile 2025
Queste note rinviano ad alcuni tra i testi più noti dell'Autore. Nello specifico, si tratta di Natale in casa Cupiello, Napoli milionaria!, Filumena Marturano, Questi Fantasmi!, Sabato, domenica e lunedì.
A tratti, si richiamano anche alcune rappresentazioni televisive, particolarmente: Natale in casa Cupiello, regia di Vincenzo Salemme (2024); Napoli milionaria!, regia di Luca Miniero (2023); Questi fantasmi!, regia di Alessandro Gassmann (2024).
Non pochi sono gli scrittori (romanzieri, drammaturghi, poeti, compositori di testi musicali) che, automaticamente, evocano in me il mistero napoletano. Tra questi, Eduardo De Filippo occupa un posto privilegiato. È tra gli autori che, oltre a richiamare Napoli e le sue peculiarità culturali e sociali, ha la forza di sondare la psicologia delle persone-quella che ne orienta la quotidianità- dando senso alla complessità delle vicende umane, quelle che accadano a Napoli come altrove. Egli fa filosofia: ma la sua è una filosofia che non si rivolge ai grandi sistemi, bensì ha origine dalla quotidianità, dalla normalità delle persone normali (trovatemi, poi, un personaggio eduardiano che sia normale) e ad essa vi ritorna.
Eduardo, io, l'ho scoperto tardi. Non che da ventenne/trentenne non l'avessi letto, che non avessi avuto la fortuna di assistere ad alcune sue rappresentazioni al Teatro San Ferdinando: ma mi irritava. Le sue trame, il suo lento incedere, il suo dialetto, le sue pause mi sembravano l'espressione di una Napoli oleografica e, in quanto tale, passata, stagnante, ancorata caparbiamente e colpevolmente alle sue tradizioni: una Napoli ostile alla modernità e alla modernizzazione, con una popolazione rassegnata alla sua rassegnazione, alla sua precarietà, alla sua arte di arrangiarsi. Alla sua cattiveria, quella derivante proprio da queste sue "qualità".
In me c'era la speranza che quella Napoli sarebbe un giorno cambiata, che il suo malessere sociale ed esistenziale sarebbe stato sconfitto, che il progresso avrebbe trionfato. Che l'arte di arrangiarsi si sarebbe prima o poi tradotta in arte di vivere e non semplicemente di sopravvivere.
Perciò, in questa prospettiva, l'opera di Eduardo mi appariva una sorta di palla incatenata al piede della città: una città che, invece, meritava il cambiamento.
Solo dopo qualche decennio ho capito che il buono di Napoli, il suo riscatto, la sua modernità, la sua arte di vivere erano-sono-racchiusi proprio in quelle opere. Anche in quelle opere.
Ho capito, cioè, che proprio Eduardo De Filippo, con l'immensità dei suoi lavori, era- ed è- la speranza.
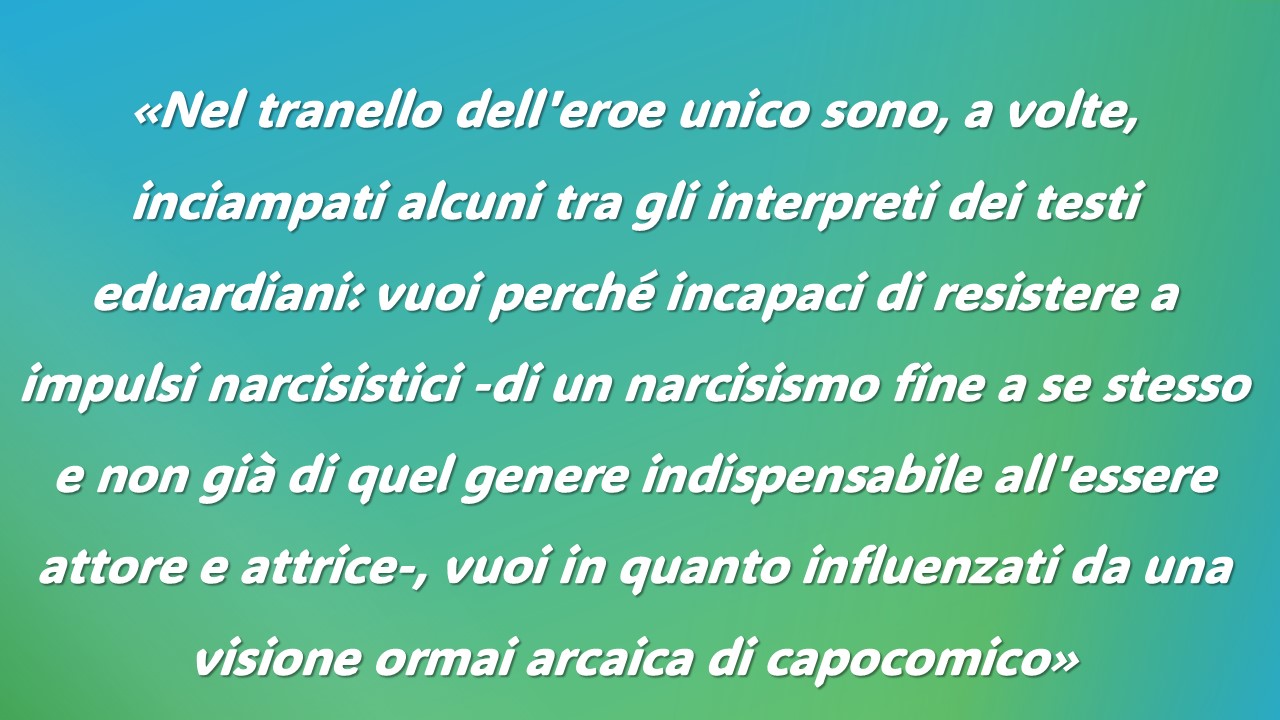
La coralità come segno distintivo delle commedie di Eduardo.
I testi sopra indicati includono, più di altri, un tratto che segna la maggior parte dei lavori dell'Autore: la coralità.
Nelle sue commedie non ci sono protagonisti unici (discorso a parte merita Filumena Marturano, di cui diremo tra poco). Il protagonista vero e unico è la storia stessa, quella che è oggetto della narrazione ed alla cui costruzione partecipano tutti i personaggi. Alcuni vi contribuiscono in misura maggiore rispetto agli altri, ovviamente, eppure la vicenda prende corpo grazie al contributo di tutti coloro che ne sono protagonisti.
Tale peculiarità risulta evidente se ci si riferisce ai testi scritti: nella loro rappresentazione teatrale, infatti, quasi per riflesso condizionato si tende a considerare eroe della vicenda il personaggio interpretato dallo stesso Eduardo nonostante egli si sia, generalmente, circondato di attori e attrici di ottimo livello.
Nel tranello dell'eroe unico sono, a volte, inciampati alcuni tra gli interpreti dei testi eduardiani: vuoi perché incapaci di resistere a impulsi narcisistici -di un narcisismo fine a se stesso e non già di quel genere indispensabile all'essere attore e attrice-, vuoi in quanto influenzati da una visione ormai arcaica di capocomico. In Natale in casa Cupiello diretto e recitato da Salemme, ad esempio, è del tutto fuori luogo quel fascio di luce che, nella scena conclusiva, cade dall'alto ad illuminare-e dunque far risaltare su tutto il resto della scena-il volto e il corpo di Luca morente.
Proprio Luca Cupiello non esisterebbe nella sua drammaticità senza tutti gli altri protagonisti: da Concetta a Tommasino, da Ninuccia a Nicola, da Vittorio a Pasqualino e gli altri, anche quelli relegati a ruoli cosiddetti minori. Una coralità che emerge pure nei momenti in cui la scena è attraversata da uno o due soli attori.
Un esempio al riguardo è il drammatico confronto tra Nicola, marito di Ninuccia, e Vittorio, amante della donna. Evento breve ma intenso che sintetizza in pochi minuti il conflitto familiare che si svolge a più livelli: tra Luca, moglie e figli, tra Ninuccia e il marito, tra la figlia e la madre, tra marito e amante. E anche tra Pasquale, fratello di Luca, e l'intero nucleo domestico:
"Pasquale: […] I parenti? Iddio ne scampi e liberi! Che belli pariente…Tengo 'e pariente, tengo! (E da dentro si fa ancora sentire) 'E pariente…Che belli pariente!", 1).
Dramma che ha il suo epilogo non solo nella semplice (si fa per dire) morte di Luca ma nel fatto che, in quel triste evento, egli scambia Vittorio per Nicola (la domanda è lecita: l'errore è autenticamente dovuto al male che sta consumando Luca oppure è un suo ultimo, strenuo e consapevole tentativo di manipolare la volontà ed i sentimenti della figlia verso il marito e l'amante?).
In ogni caso, si tratta di un momento di intensa coralità e in cui ogni protagonista è chiamato a confrontarsi con la sua coscienza (altro che fascio di luce luminoso che scende dall'alto…).
Tutti, insomma, sono eroi e, allo stesso tempo, nessuno lo è in maniera esclusiva.
Forse il vero eroe solitario è proprio il presepe (cosa sarebbe Luca Cupiello senza il presepe?), su cui convergono le diverse energie che animano il conflitto familiare.
È, infatti, attraverso il presepe che Luca Cupiello vuole affermare la sua autorità patriarcale e le tradizioni su cui essa poggia (e traballa). L'esempio classico a riguardo è l'insistenza con cui chiede al figlio, già conoscendone la risposa, se gli piace 'o Presebbio.
Sempre il presepe è l'oggetto della protesta di Tommasino verso tale autorità: allo stesso tempo, ribellione nei riguardi della pigrizia mentale del genitore che, e Tommasino lo avverte anche solo epidermicamente, fa del presepe la cortina fumogena dietro cui ripararsi per non prendere piena coscienza del dramma familiare di cui egli è il principale artefice.
Anche Concetta fa del presepe lo strumento con cui manifesta, seppur debolmente, la sua disapprovazione verso l'ignavia del marito.
"Concetta (tornando con il barattolo di colla fumante) 'A colla… (raggiunge il tavolo dov'è il Presepe per collocarvi sopra il barattolo di colla) Io nun capisco che 'o faie a ffa', stu Presebbio. Na casa nguaiata, denare ca se ne vanno…E almeno venisse bbuono!", 2).
Verso il presepe si scaglia materialmente la rabbia di Ninuccia, figlia esasperata dalle imposizioni familiari che l'hanno costretta-e la vorrebbero ancor obbligare-ad un matrimonio con un uomo che lei non ama, Nicola, e, allo stesso tempo, ad allontanare da sé il vero amore della sua vita, Vittorio.
Sempre il presepe è al centro della scena finale quando Tommasino finalmente risponde "Sì" alla domanda che Luca gli rivolge per l'ultima volta in punto di morte: "Tommasi', te piace 'o Presebbio?", 3).
L'eroismo della famiglia Jovine.
Anche Gennaro Jovine, in Napoli milionaria!, è una figura che, per esistere in tutta la sua complessità necessita dell'apporto degli altri personaggi. È, questa, un'altra opera in cui non emerge un eroe unico e solo. O, meglio, come accade nelle altre commedie, esistono tanti eroi unici e soli quanti sono i momenti più significativi dell'intera vicenda.
Lo è Gennaro, un eroe solitario, quando affonda nel senso di estraneità che lo investe nel suo rientro a casa (tanto cambiata che, all'inizio, nemmeno la riconosce ed anche quando la riconosce non l'avverte più come sua) dopo l'anno di prigionia:
"Gennaro: ([…] Nel varcare la soglia dà un fugace sguardo intorno e ha un senso di sorpresa. La sua meraviglia poi giunge al colmo nel vedere la moglie in quell'abbigliamento così lussuoso. Quasi non la riconosce e, convinto si essersi sbagliato di porta, fa un gesto di scusa alla donna dicendo rispettosamente) Perdonate, signora… (Ed esce)", 4).
È eroe solitario quando il desiderio/bisogno di narrare le sue tristi vicende viene puntualmente eluso da familiari ed amici; lo è nel momento che risulta essere il solo, lì, tra coloro che in casa e nei vicoli festeggiano la fine della guerra, ad aver capito che la guerra per nulla è finita: e non si tratta, quella a cui egli pensa e che teme, della guerra ancora combattuta nel resto di Italia e in Europa, ma dello scontro - morale e culturale, privato e collettivo- tra passato e presente/futuro. Uno scontro che si prolungherà ancor più del conflitto armato con conseguenze nefaste per la famiglia Jovine e la stessa città di Napoli.
Anche per donna Amalia Jovine sono diversi i momenti in cui è lei eroina solitaria. Lo è non tanto quando si prodiga nella disperata ricerca del farmaco necessario a salvare la vita di Rituccia- lo è, solo che in tal caso si tratta di un eroismo, diremmo, di prassi-ma principalmente quando si lacera tra il ricordo del marito disperso e che lei-unica tra tutti-non crede morto (sente che non è morto) e la tentazione di cedere alle avances di Errico "Settebellizze".
"Amalia:[…] Vivo, è vivo! Pe' nun fa' sapé niente, è segno che non ha potuto…Ma vedite che, da un giorno all'altro, 'o tengo nnanze a ll'uocchie, Gennarinoi sta ccà.
Errico: (messo di fronte all'evidenza, trova modo di insinuare) Certo ca pe' vuie sarà nu piacere.
Amalia (combattuta): Nu piacere e nu dispiacere Pecché certamente, vuie 'o ssapite…accumencia a dimmannà… «Ma che d'è stu cummercio?...Chesto se po' fa'…chello no…» Insomma, mi attacca le braccia ca nun pòzzo cchiù manovrare liberamente…
Errico:(avvicinandosi sempre più a lei e fissandola, quasi con aria di rimprovero) Già…
Amalia (volutamente sfugge):«O pericolo…Stàmmece accorte…»
Errico: E…non per altra ragione?
Amalia: Per tutte queste ragioni.
Errico (indispettito, come richiamando la donna a qualche promessa tutt'altro che evasiva) E pe' me, no? E ove'? Pe' me, no?
Amalia: (Non avendo più la forza di fingere, per la prima volta, guarda l'uomo fisso negli occhi e, stringendogli le braccia lentamente e sensualmente gli mormora) E pure pe' te!", 5).
Amalia, di fatto, è sempre un'eroina. Sempre tesa tra famiglia e spasimante. Tra rettitudine e bisogno di fuggire alla miseria (fuga che, a volte, costringe a cedere al richiamo dell'illecito, dell'immorale, del disordine emotivo, del degrado relazionale). E donna Amalia esprime il suo conflitto interiore attraverso comportamenti costantemente aggressivi perché difensivi. Ma non è certo la donna isterica (nel senso di instabile) che ci propone Valeria Scalera in Napoli milionaria! film/tv del 2023, regia di Luca Miniero.
Ha il suo momento di eroismo anche il brigadiere Ciappa quando intuisce quanta sia fasulla la morte di Gennaro: ma senso di umanità, di comprensione, di accettazione lo conduce a temporeggiare fino a promettere l'immunità al falso defunto se solo gli dà la soddisfazione di mostrare il bluff.
Ed è eroico il figlio, Amedeo, quando sceglie l'etica familiare al richiamo del facile, ed illecito, guadagno.
La fase finale dell'opera costituisce, come in Natale in casa Cupiello, un momento di estrema coralità, quando di fronte all'incertezza sulla salute di Rituccia convergono i destini di tutti i protagonisti: morte di Luca e la vita in bilico della povera bambina costituiscono una sorta di nemesi per entrambe le famiglie.
E quando Gennaro si rivolge alla moglie dicendo:
"[…] S'ha da aspettà, Ama'. Ha da passà 'a nuttata", 6)
si sta riferendo a una nuttata che riguarda non solo la famiglia Jovine ma l'intera popolazione napoletana.
"E a noi lettori/spettatori, a quel punto, non interessa più capire se Pasquale ci fa o ci è, se finge di non sapere che si sta rivolgendo ad una persona in carne ed ossa, tra l'altro amante della moglie, oppure se crede che stia parlando effettivamente ad un fantasma"
Quando l'eroe è un fantasma.
L'elemento corale emerge anche in Questi fantasmi!, dove l'azione di Pasquale Lojacono, intrisa di ambiguità e di una superstizione "di comodo", è costantemente controbilanciata dagli altri protagonisti.
Nelle fasi iniziali assume rilievo la figura di Raffaele, il portiere del palazzo in cui Pasquale occupa gratuitamente un maestoso appartamento: gratuitamente, dunque, a patto che, come richiesto dal proprietario, si adoperi affinché convinca la gente del quartiere che quella casa è libera da oscure presenze. Quindi, mostrandosi sempre sereno e sorridente, che metta a tacere quelle dicerie sul via vai di fantasmi che impediscono al proprietario di fittare l'appartamento.
È proprio Raffaele a definire al meglio la figura di Lojacono come borghese, pur se un borghese alla soglia del fallimento economico (quello familiare, ormai, è certo), dunque come rappresentate di quella classe sociale a cui il "popolino" ha sempre qualcosa da chiedere (da pretendere) e da cui il borghese deve sempre, in qualche modo, difendersi.
"RAFFAELE: A proposito, signurì…noi poi ci mettiamo d'accordo per il mensile mio.
PASQUALE: Ne parleremo.
RAFFAELE: E mo ce truvammo, pecché non ne parlammo mo? Io non ci tengo, ma 'e solde 'e voglio.
PASQUALE: Nun ci tieni, ma 'e solde 'e vvuò!
RAFFAELE: Mannaggia 'a capa d' 'o ciuccio…Signò…io veramente non ci tengo, pecché non ci tengo; ma se poi proprio non ci tengo, a fine 'o mese che tengo?", 7).
Pasquale è ben poca cosa senza gli altri personaggi, insomma, e principalmente senza il suo fantasma personale, dietro cui si nasconde e attraverso cui si assolve dall'ignorare la relazione di sua moglie Maria con Alfredo. Lo fa per vigliaccheria pura e semplice o per necessità materiali (il "fantasma" gli fa interessanti donazioni alimentari e, poi, economiche)? Insomma, Pasquale ci crede o non ci crede nei fantasmi? Almeno, in quel fantasma?
Quel che Pasquale sa è che, senza quel fantasma, lui non esiste materialmente e moralmente. Materialmente, perché finiranno le donazioni. Moralmente, in quanto sarà costretto ad ammettere che Maria ha un amante.
Lojacono ha bisogno anche del professor Santanna, che l'Autore, nella presentazione dei personaggi, definisce "anima utile, che non compare mai".
Il professore, infatti, è una presenza muta a cui Pasquale si rivolge come parlando a uno specchio. O alla sua coscienza. O direttamente al pubblico 8).
È al professore che, ad un certo punto, egli si confessa, più che altro per confessare a se stesso, che i fantasmi non esistono, che li creiamo noi perché ci conviene, perché servono a deresponsabilizzarci, a giustificare quel che facciamo e che non vorremmo fare perché costretti a farlo (ricordiamo, qui, le scelte obbligate di Amalia Jovine).
"PASQUALE: […] Non è vero niente, professo': ah…ah…ah…Non è vero! I fantasmi non esistono, li abbiamo creati noi, siamo noi i fantasmi", 9).
Pasquale è, alla fine, tutt'uno con il suo fantasma. E gli parla, gli parla direttamente, proprio come se parlasse ad un essere vivente, gli parla per chiedergli aiuto, per chiedergli di salvarlo dal baratro economico.
"PASQUALE: […] Férmate…T'aggi' 'a parlà!" , 10).
E a noi lettori/spettatori, a quel punto, non interessa più capire se Pasquale ci fa o ci è, se finge di non sapere che si sta rivolgendo ad una persona in carne ed ossa, tra l'altro amante della moglie, oppure se crede che stia parlando effettivamente ad un fantasma. Quel che gli interessa, a quel punto, è che quella presenza, umana o no, soddisfi i suoi bisogni. E quando si accorge che il fantasma, ovvero Alfredo, gli ha lasciato una cospicua somma di denaro ringraziandolo, tra l'altro, perché:
"ALFREDO: […] Hai sciolto la mia condanna. Io fui condannato a vagare per questa casa fino a che un uomo non mi avesse parlato come mi stai parlando tu", 11)
spera che il fantasma ritorni, semmai sotto altre sembianze.
Di fantasmi, ci dice Pasquale, si ha sempre bisogno.
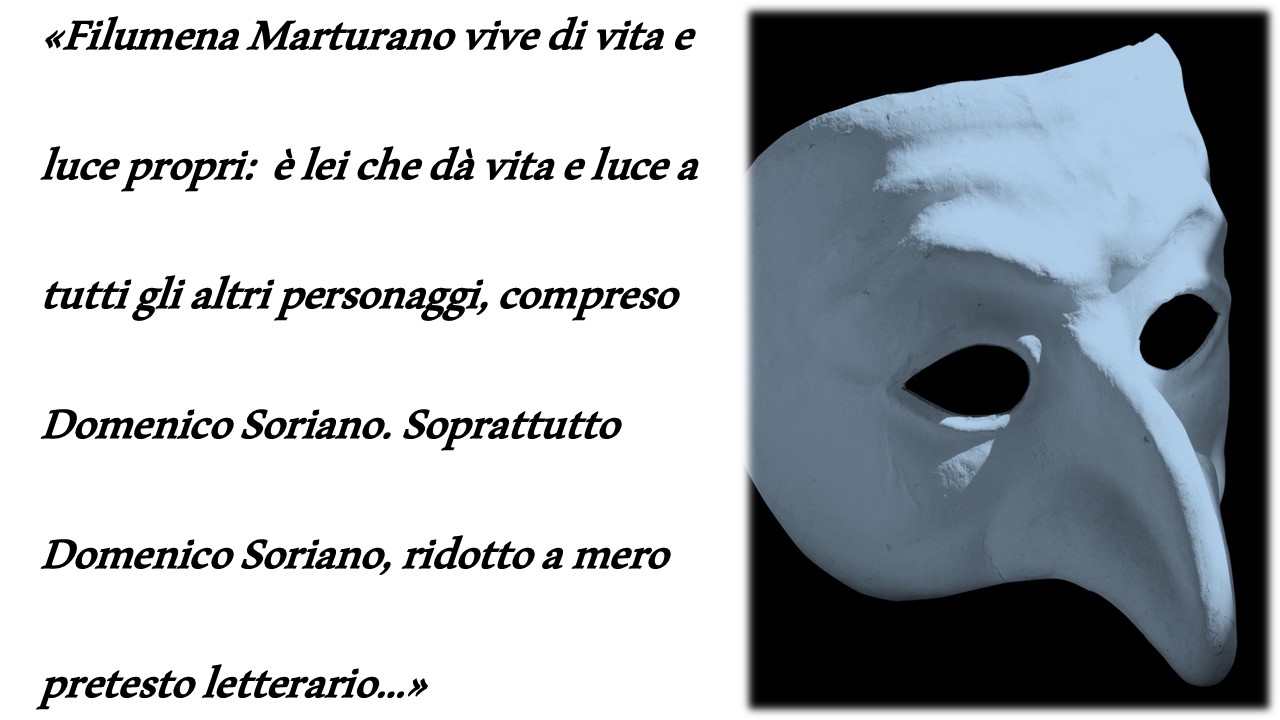
Filumena Marturano, la vera ed unica eroina solitaria.
Inarrivabile. Intoccabile. Insuperabile. Eterna.
Irrecitabile, se non dalle grandi attrici. Dalle Attrici.
Filumena Marturano è tutto questo e ben altro.
Definirla "personaggio" è riduttivo. È fuori luogo. È offensivo.
Filumena è presenza. Filumena è.
È la vera ed unica eroina solitaria: si erge al di sopra dell'opera e dell'autore stesso. Filumena segue il destino delle grandi figure letterarie classiche diventate anch'esse "presenze", quelle che non appartengono più all'autore, al loro creatore: appartengono a se stesse e, allo stesso tempo, a tutti noi, a patto che le comprendiamo e le rispettiamo.
Al riguardo, mi vengono in mente Medea, Ulisse, Amleto, Faust, Don Chisciotte, Gregorio Samsa…giusto per citarne alcune, di queste figure letterarie: figure senza tempo, senza origine né destinazione, eppure tanto consistenti da lasciare tracce indelebili-di cui non sempre siamo consapevoli-nel nostro immaginario.
Filumena Marturano vive di vita e luce propri: è lei che dà vita e luce a tutti gli altri personaggi, compreso Domenico Soriano. Soprattutto Domenico Soriano, ridotto a mero pretesto letterario affinché il valore di Filumena possa declinarsi in storia narrabile.
Filumena racchiude in sé la vita in tutti i suoi aspetti, a cominciare dalla sofferenza:
"FILUMENA: […] Saie quanno se chiagne? Quanno se cunosce 'o bbene e nun se pò avé! Ma Filumena Marturano bene nun ne cunosce…e quanno se cunosce sulo 'o mmale nun se chiagne. 'A suddisfazione 'e chiagnere, Filumena Marturano, nun l'ha pututa maie avé!", 12).
E poi conosce la dignità. Filumena è la dignità fatta personaggio. O meglio, fatta persona:
"FILUMENA (seria): 'E figlie so' ffiglie!
DOMENICO: E che vuo' dicere?
FILUMENA: Hann' 'a sapé chi è 'a mamma…Hann' 'a sapé chello c'ha fatto pe' lloro…M'hann' 'a vulé bene! (Infervorata) Nun s'hann' 'a mettere scuorno vicino all'at' uommene: nun s'hann' 'a sentì avvilite quanno vanno pe' caccià na carta, nu documento: 'a famiglia, 'a casa…'a famiglia ca s'aunisce pe' nu cunziglio, pe' nu sfogo…S'hann' 'a chiammà comm' a mme!", 13).
Filumena sa sacrificarsi in nome della sua dignità e perché spinta dal suo valore supremo: l'amore per i figli.
"FILUMENA: […] Statte bbuono, Dummi'…E ricuòrdate; si chello che t'aggio ditto 'o ddice a 'e figlie mieie…t'accido! Ma no comm' 'o ddice tu, ca me l'he ditto pe venticinc'anne…comme t''o ddice Filumena Marturano: t'accido! Hai capito?? […] He vinciuto 'o punto. Me ne vaco. […] (Prende dal seno un medaglione, lo apre e ne estrae, ripiegato diverse volte, un consunto biglietto da cento. Ne strappa un pezzetto, poi a Domenico) Ci avevo segnato sopra un conticino mio, nu cunticiello ca me serve. Tiene (Poggia un biglietto sul tavolo e, con tono quasi allegro, ma profondamente sprezzante, gli dice) 'E figlie nun se pàvano!", 14).
Filumena sa lottare, sa lottare come solo lei sa fare. Come solo la Donna e la Madre sanno fare. Neanche il destino la spunta con Filumena: è lei a forzarlo fino a far sì che si realizzi ciò che sembrava impossibile che avvenisse, ciò a cui lei sembrava mai e poi mai destinata. Filumena è tanto forte, è tanto in assoluto, da strappare al destino quel che il destino, quasi per dispetto, le aveva sempre negato: i figli. Una famiglia. Un marito.
"FILUMENA (felice): Dummì, sto chiagnenno…Quant'è bello a chiagnere…", 15).
"La risposta, ovviamente, è no. Anzi, la trasmissione dell'opera attraverso gli anni e la sua diffusione oltre i limiti geografici avvengono essenzialmente attraverso i suoi interpreti.
E poi, un prodotto artistico, particolarmente se rispetta i canoni classici, una volta creato non appartiene più al suo autore"
Solo Eduardo può recitare Eduardo?
Sono convinto che Eduardo De Filippo mai abbia scritto esclusivamente per se stesso. Mai pensando solo a se stesso come unico in grado di recitare i personaggi intorno ai quali, nelle sue opere, ruota l'intera vicenda. Il solo Luca Cupiello possibile. Il solo Gennaro Jovine accettabile. L'unico Pasquale Lojacono degno. E così con Domenico Soriano (pur se da "spalla" a Filumena) … con Peppino Priore, e via di seguito.
Eduardo ha scritto, ne sono convinto, per dare vita a personaggi che incarnassero quei pregi e difetti riscontrabili, mediamente, nell'intera umanità. Quei tratti caratteriali-caratteristici- che orientano la quotidianità di tutti noi, che ne segnano i piccoli e i grandi gesti, che guidano comportamenti minimi e complessi. L'umanità intera, dunque, e non solo la gente dei vicoli e dei quartieri di Napoli. Anche se, spesso, è proprio dai vicoli che le sue narrazioni hanno origine.
Eduardo De Filippo ha scritto per il pubblico. Per il teatro. Teatro inteso come dimensione di vita, spazio culturale, strumento di indagine della psiche umana. E, ci mancherebbe, come fonte di piacere intellettuale, emotivo, fisico.
L'opera di Eduardo appartiene al suo tempo e, contemporaneamente, lo supera fino a diventare senza tempo. Diremmo, perciò, eterna.
In questa prospettiva il teatro di Eduardo può, deve, ritenersi un classico.
Ecco che, allora, quando accade che ci si approccia al classico, quando attori e attrici si apprestano a interpretare i personaggi eduardiani, quando si lavora sulla regia dell'opera, sulla sua scenografia, le sue musiche, inevitabilmente sorgono alcune questioni di particolare rilievo, ovvero fino a che punto:
1. è lecito rivisitare la struttura tradizionale dell'opera?
2. è possibile innovare senza contravvenire al messaggio dell'autore classico?
3. va rispettata la tradizione?
4. è lecito fare il confronto tra rappresentazione originale e reinterpretazione?
Quesiti che, ovviamente, almeno nel caso di Eduardo De Filippo, si condensano in un solo grande interrogativo: solo Eduardo può recitare Eduardo?
La risposta, ovviamente, è no. Anzi, la trasmissione dell'opera attraverso gli anni e la sua diffusione oltre i limiti geografici avvengono essenzialmente attraverso i suoi interpreti.
E poi, un prodotto artistico, particolarmente se rispetta i canoni classici, una volta creato non appartiene più al suo autore. Ciò, comunque, non implica che si possa farne l'uso che si vuole. La "libera proprietà" del prodotto, il suo essere insomma di tutti e di nessuno, non significa che si possa arbitrariamente dissolvere il suo nucleo fondante-culturale, filosofico, storico-sociale- in nome della libertà di espressione- espressione a volte utilizzata da chi dice qualcosa senza avere la benché minima idea di cosa stia parlando-della molteplicità dei gusti artistici, della varietà delle prospettive attraverso cui è possibile interpretare la realtà e, dunque, anche un'opera d'arte.
A partire da quest'assunto, allora è opportuno fissare alcuni princìpi che, in qualche modo, rappresentano una risposta alle questioni di poc'anzi:
1. i gusti sono molteplici, e meno male. Il gusto artistico poggia su una varietà di elementi non tutti e non sempre spiegabili attraverso la ragione. Il gusto è personale. È legato alla propria storia (forse), al proprio contesto socio-culturale (forse), al momento storico in cui ci si trova involontariamente collocati, alla propria competenza linguistica (forse)…
L'arte, però, è altro: ha un suo nucleo oggettivo e, principalmente, ha il potere di metterci in contatto-a volte per brevissimi intervalli di tempo- con emozioni e sensazioni che non sperimentiamo in nessun'altra occasione della nostra quotidianità, per quanto possa trattarsi di circostanze piacevoli. L'arte, insomma, ci mostra quella zona oscura (non perché malefica ma perché non è normalmente sperimentabile) della realtà e di noi stessi con cui conviviamo ma, in genere, senza saperlo. Solo l'arte ce ne rende coscienti.
L'arte, dunque, è arte se e solo se ci mette in contatto con tutto ciò a cui mai possiamo accedere con la sola ragione. O con quell'emotività che non ci disorienta perché è quella che ci aspettiamo di provare in quella data circostanza.
Una commedia, perciò, può essere ben recitata, intelligente e gradevole: ma non necessariamente è un'opera d'arte. Così un brano musicale. Un libro. Un quadro. Una scultura.
2. Ogni opera teatrale è interpretabile. Ogni rivisitazione, però, deve rispettare quei principi che rendono quel prodotto un'espressione artistica: altrimenti è un'altra cosa.
3. Ogni opera teatrale è interpretabile, dicevamo: l'interpretazione, però, deve evidenziarne gli aspetti più significativi o deve mostrarne nuovi. La rivisitazione dell'originale deve aggiungere, non togliere. O ridicolizzare. Purtroppo è quanto è accaduto, in tempi recenti, alle opere eduardiane proposte in TV.
4. Il confronto: spesso, quando ci si appresta ad assistere alla rilettura di un'opera teatrale, si viene esortati- o ci si propone- a non fare confronti tra la nuova versione e quella originale. Nel caso di Eduardo, è una costante. Particolarmente, si invita a non assumere come riferimento lo stile attoriale dell'Autore.
Perché? Per quale motivo all'artista che si assume l'onere e l'onore di portare in scena un'opera eduardiana dovrebbe essere risparmiato il confronto? Tra l'altro, il confronto non è tanto con Eduardo attore-autore, bensì con i suoi personaggi e la loro simbologia: che si tratti di Filumena (essere speciale), di Pasquale Lojacono, di Gennaro e Amalia Jovine, di Luca Cupiello e suo figlio Tommasino (figura spesso trascurata e banalizzata nelle varie riletture di Natale in casa Cupiello), Peppino e Rosa Priore, giusto per citarne alcuni…senza dimenticare personaggi solo in apparenza minori (tali ritenuti soltanto nelle rivisitazioni e non certo negli originali), come, ad esempio, Carmela 'a sorella do guardaporte in Questi fantasmi!...e lo stesso guardaporte, Raffaele. O Aglietiello, in Non ti pago.
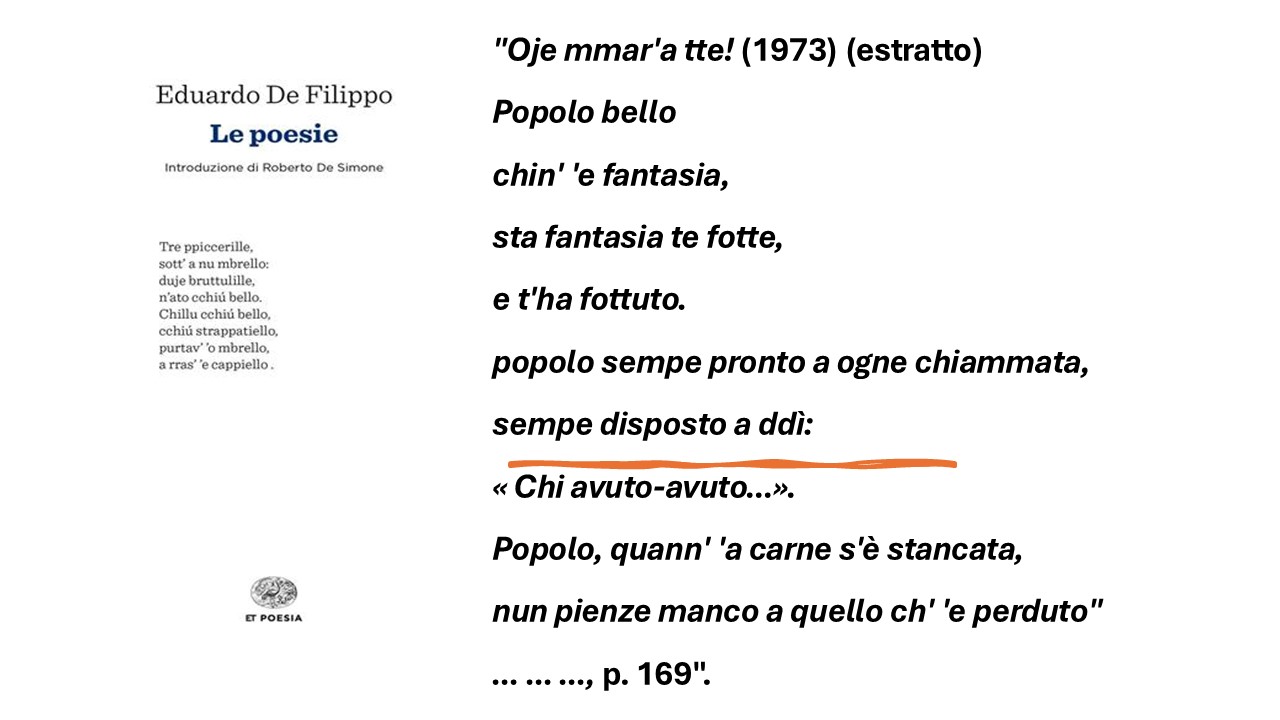
Lo strascinare i piedi di Eduardo
Strascinare i piedi è un tratto caratteristico dello stile di Eduardo De Filippo attore.
È, quello, un movimento che pare debba incepparsi ad ogni passo. Sembra che sia sul punto di interrompersi come se, di fronte al personaggio, si parasse improvvisamente un ostacolo invisibile solo allo spettatore. Invece, quel camminare è solo apparentemente stentato: procede, infatti, fluidamente portando con sé e in sé la fatica del vivere quotidiano, una fatica che include alcuni paradossi: consapevolezza e ignoranza, speranza e rassegnazione, voglia di lottare e desiderio di quiete, gioia e dolore, paura e (tanto) coraggio.
È quel medesimo gesto che, quando è ripreso da altri attori, resta, a volte, nonostante la bravura degli interpreti, proprio quel che è in apparenza: un semplice strascinare i piedi. Una forma di indolenza, dunque, o il segno di una difficoltà puramente fisica. Una fatica del vivere che è essenzialmente una questione anagrafica. Un male del corpo, insomma, più che dell'anima.
Lo stesso ritmo lento ma preciso si ritrova in alcune delle sue poesie: lente, affaticate, come se le parole si ponessero una dietro l'altra solo per dovere. Invece, sostengono ognuna il peso di un preciso ed inevitabile significato.